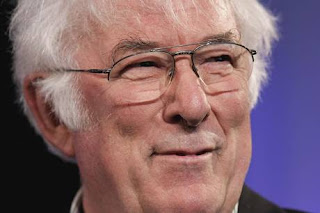Autore: Angelo Paulon

Quella dello “scontro di civiltà” viene spesso considerata, in Europa e negli USA, una teoria che preconizza un più o meno prossimo conflitto radicale tra il mondo islamico e quello occidentale. Comprensibilmente, lo choc dovuto all’11 settembre e alle sue conseguenze (le guerre in Afghanistan e Iraq, la caccia a Bin Laden, la lotta contro Al Qaeda, …) fa in modo che, in Occidente, ci si concentri soprattutto sull’inconciliabilità (o supposta tale, a seconda dei punti di vista) tra i valori fondanti le democrazie di stampo liberale e quelli alla base dell’Islam. È poi singolare notare come quando vi sono notizie di scontri interetnici o interreligiosi che non vedono direttamente coinvolti cittadini occidentali o gruppi di cristiani, a essere sotto la lente d’ingrandimento è soprattutto il Medio Oriente, data la sua prossimità geografica all’Europa e la sua importanza globale in termini geopolitici. Eppure, anche qui, quando gli scontri non sono più breaking news o quando i conflitti si incancreniscono e diventano duraturi (vedi Siria), lo spazio dedicato a questi avvenimenti e l’interesse dell’opinione pubblica tendono a scemare piuttosto velocemente.
In realtà, gli scontri tra diversi gruppi confessionali e/o etnici che non appartengono, né geograficamente né culturalmente, al mondo occidentale sono all’ordine del giorno. Non si tratta di avvenimenti sporadici e occasionali, quanto di episodi organizzati e pianificati nel contesto di conflitti molto più ampi. L’escalation cui si assiste è impressionante, e l’ondata di attentati che ha insanguinato l’Iraq provocando una novantina di morti in occasione delle festività per la fine del Ramadan (10 agosto) ne è solo l’ultimo esempio in ordine di tempo. Questi specifici attacchi riguardano lo scontro, tutto interno all’Islam, tra sunniti e sciiti. Lo dimostra la puntuale rivendicazione di Al Qaeda, giunta tramite l’organizzazione radicale affiliata che si definisce Stato Islamico dell’Iraq e del Levante. I terroristi hanno rinnovato le loro minacce agli sciiti, che a loro dire non potranno più sentirsi al sicuro.
Ma ci sono anche altri fronti molto caldi nel mondo. In Asia si assiste, già da tempo, a una recrudescenza nelle violenze tra buddisti e musulmani. Qualche dato di cronaca può illustrare la situazione in maniera chiara. 2004: nelle province più meridionali della Thailandia, al confine con la Malesia, prende il via un’insurrezione contro il governo centrale. La guerra civile tra esercito e separatisti locali, popolazioni a maggioranza musulmana, sino a oggi ha provocato almeno 5.000 vittime. 2012: a giugno e a ottobre, nella regione di Rakhine (Myanmar occidentale) esplodono violentissimi scontri interreligiosi tra buddisti e musulmani di etnia Rohingya; si contano almeno 80 morti e decine di migliaia di sfollati (vi è un’ostilità di lunga data tra i birmani, in particolare i buddisti Rakhine, e i Rohingya, che gli abitanti del luogo non considerano come compatrioti. Il governo del Mynmar, dal canto suo, sostiene la tesi che i Rohingya sono immigrati in tempi relativamente recenti dal subcontinente indiano e dunque non posseggono i requisiti di “popolazione indigena” per avere la cittadinanza birmana). A seguito delle violenze, non meno di 30.000 persone trovano rifugio in Bangladesh, che però ne rimanda indietro a migliaia. L’ONU deve intervenire per sollecitare il Bangladesh ad accogliere i profughi per ragioni umanitarie. Marzo 2013: più giorni consecutivi di scontri nella città di Meiktila (Myanmar centrale) lasciano sul terreno almeno 40 persone, in maggioranza musulmani. Aprile 2013: in un campo profughi di Belawan, nel settentrione di Sumatra (Indonesia), carneficina con 8 buddhisti birmani morti e 20 feriti tra buddhisti e musulmani Rohingya. Maggio 2013: le violenze deflagrano nella città di Lashio, nella regione dello Shan (Myanmar nord-orientale). 4 agosto 2013: un doppio ordigno esplode all’interno del tempio buddista Ekayana a Jakarta (Indonesia), ferendo tre persone. 10 agosto 2013: un gruppo di estremisti buddisti attacca una moschea di Colombo (Sri Lanka) scontrandosi con gli abitanti musulmani della zona; si contano almeno cinque feriti e la polizia è costretta a imporre il coprifuoco.
Scorrendo questo pur breve elenco, sono due i fattori a risultare più evidenti: la frequenza con cui gli scontri avvengono e la loro diffusione territoriale.
Non c’è dubbio che ogni situazione faccia storia a sé. In Thailandia, per esempio, le province meridionali di Narathiwat, Yala e Pattani sono a netta maggioranza musulmana e un tempo erano un sultanato autonomo, Malay. Questi territori costituiscono la base operativa di vari gruppi separatisti di matrice islamico-fondamentalista, che mirano all’autonomia dalla Thailandia e, se possibile, alla rinascita del sultanato.
Nello Sri Lanka, i buddisti accusano i musulmani di controllare settori chiave del commercio e della finanza cingalese e di spingere la popolazione buddista a convertirsi all'Islam. Per di più, il buddismo si fonde all’etnia in un processo di identificazione che tende a privilegiare l’elemento nazionale radicalizzando le differenze con “gli altri”. Ecco allora che organizzazioni come il BBS (Bodu Bala Sena, traducibile a grandi linee come “forza buddista”) hanno gioco facile a riscuotere successo tra la popolazione grazie a una posizione politica fortemente intollerante verso i musulmani, il cui alto tasso di natalità è percepito come pericoloso, in prospettiva, per l’identità nazionale.
Nel Myanmar la situazione è, se possibile, ancora più drammatica. Le violenze del 2012 e dell’anno in corso hanno già provocato, oltre a decine di morti, più di 100.000 senza tetto. La città di Sittwe, nella regione di Rakhine, è ormai svuotata dei suoi abitanti di fede musulmana, costretti a trasferirsi in squallidi campi profughi ai margini della città. Il meglio cui costoro possono aspirare è raggiungere via mare la Malesia su qualche malandato peschereccio, nella speranza di superare indenni la traversata. Le tensioni interreligiose sono alimentate anche da un movimento di monaci birmani, che invita a boicottare negozi e attività dei seguaci di Maometto. L’esponente di punta di questo movimento è il celebre monaco Wirathu, conosciuto come il “Bin Laden birmano”. Intervistato nei mesi scorsi dal settimanale Time, ha apertamente espresso la propria visione delle cose: “[Muslims] are breeding so fast and they are stealing our women, raping them […] They would like to occupy our country, but I won’t let them. We must keep Myanmar Buddhist”. La stessa Aung San Suu Kyi, premio Nobel per la Pace, è stata più volte criticata dai gruppi internazionali a tutela dei diritti umani per non aver chiarito la sua posizione sui problemi delle popolazioni coinvolte dall’ondata di odio e violenza diffusa in diverse città.
Bisogna però fare attenzione a non etichettare questi conflitti come semplici questioni interne ai vari paesi. In realtà, le violenze interconfessionali hanno già provocato importanti reazioni a livello internazionale. Si sono avute manifestazioni pacifiche, come una marcia di solidarietà ai Rohingya tenutasi a Mumbai, in India, da parte della comunità musulmana locale. Ma vi sono stati anche attacchi terroristici: il 7 luglio uno dei siti più importanti per il buddismo indiano, il Bodh Gaya di Bihar, è stato oggetto di un attentato molto probabilmente opera di un gruppo islamico. Non sono mancate altre prese di posizione ostili nei confronti dei buddisti e solidali con i musulmani. In Indonesia, il più popoloso stato islamico del mondo, sono state organizzate molte raccolte di fondi a favore dei Rohingya. La solidarietà religiosa ha però preso anche una piega più violenta: ad aprile un religioso islamico radicale, Abu Bakar Basyir, ha chiamato alla jihad contro i buddisti del Myanmar. Forse non casualmente, in maggio due uomini sono stati arrestati perché sospettati di pianificare un attentato con pipe-bombs contro l’ambasciata birmana di Jakarta. Non è tutto: secondo ambienti vicini ai servizi di sicurezza, pare che lo scorso 19 giugno si sia tenuto a Jakarta un meeting tra il Forum Umat Islam, un gruppo estremista indonesiano, e due esponenti della Rohingya Solidarity Organization (RSO). Lo scopo potrebbe essere stato quello di studiare come fornire armi ai Rohingya affinché costoro possano contrattaccare. Di certo, sembra abbastanza plausibile che i Rohingya cerchino supporto tra altri gruppi di correligionari. Così come pare logico pensare che l’intervento, diretto o indiretto, di altri gruppi terroristici nell’area non promette niente di buono.
Pur nelle specificità nazionali, che non possono essere sottovalutate, stanno emergendo con sempre maggiore chiarezza un paio di fattori comuni a questi conflitti. Il primo è il già parzialmente citato processo di identificazione etnico-religiosa che porta il buddismo a diventare trait d’union tra diversi elementi della società, sia in vista di un rafforzamento dell’identità nazionale che in funzione anti-islamica. Processo al quale si sommano e con il quale si combinano elementi di contingenza e convenienza politica. In Myanmar, ad esempio, c’è la concreta possibilità che alcuni partiti di minoranza (segnatamente la National Democratic Force, NDF) presentino un progetto di legge (sponsorizzato da Wirathu e dai suoi seguaci) volto a limitare la possibilità di matrimoni interconfessionali. Il tutto per puro calcolo elettorale, al fine di far leva sui sentimenti nazionalistici e anti-islamici della popolazione buddista e guadagnare voti per tentare di evitare la più che probabile vittoria a valanga alle prossime elezioni del partito di Aung San Suu Kyi, la National League for Democracy (NLD).
Il secondo fattore comune alle violenze è, forse sorprendentemente, il ruolo dei monaci. L’immagine del buddismo come religione della tolleranza e della non violenza esce da questi mesi di scontri piuttosto modificata. È vero che, da un lato, i monaci possono essere usati come delle pedine in un gioco strategico più sofisticato e che la loro presenza può fornire una copertura ideologica ai conflitti (è il caso, ancora una volta, del Myanmar, dove non si può escludere che le attuali tensioni siano orchestrate anche da ex appartenenti alla giunta militare che governava il paese. Ora questi elementi potrebbero mirare a portare instabilità nel paese, per minare le riforme politiche in chiave democratica degli ultimi tre anni). Ma è altrettanto evidente che emerge, nello Sri Lanka e in Myanmar, così come in Thailandia, una forte militanza patriottica fra i monaci buddisti, sempre più inestricabilmente legati agli eserciti, dai quali ricevono protezione. in Thailandia, ad esempio, monaci ed esercito fanno apertamente fronte comune; i religiosi consentono alle forze armate di usare i templi come basi operative contro i ribelli musulmani e ci sono anche casi di monaci-soldato: “In fighting the Muslim insurgents, the Thai army has become inextricably bound up with Buddhist monks. Temples are used as army bases, and “soldier monks” are said to operate”. Per converso, i ribelli ritengono i monaci come obiettivi specifici da colpire, in quanto vengono visti come simbolo dell’autorità del governo thailandese. A riprova del sempre più stretto legame tra religione, nazionalità e autorità governativa. Legame che, sul fronte opposto, è giocoforza utilizzato in chiave anti-islamica e anti-separatista.
In conclusione, quindi, sembra proprio che elementi comuni alle singole situazioni interne di vari paesi, propaganda, reti di solidarietà confessionale, aiuti economici e militari transnazionali (veri o presunti) rendano le tensioni sempre meno un fattore interno ai vari stati e sempre più un confronto totale tra due delle più grandi religioni dell’Asia. Nei primi mesi di quest’anno sono iniziati i colloqui di pace ufficiali tra il governo di Bangkok e i ribelli islamici delle province del sud, rappresentati dal gruppo Barisan Revolusi Nasional. Si sono tenuti già tre round di questi negoziati, sotto l’auspicio della Malesia, paese nel quale si tengono gli incontri. C’è da augurarsi che le parti riescano a trovare un accordo che possa, se non porre termine al conflitto thailandese, almeno costituire un buon punto di partenza per smorzare la tensione nell’area e abbassare la temperatura in una zona già di per sé molto calda. Se, al contrario, non si dovesse trovare nessuna soluzione, i rischi di una nuova escalation di violenze interconfessionali aumenterebbero esponenzialmente. E qualsiasi ulteriore diffusione dell’incendio non sarebbe certo un bel segnale per il continente…
Fonti:
http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2013/08/2013811214511140106.html
http://www.heraldsun.com.au/news/breaking-news/al-qaeda-claims-iraq-deadly-attacks/story-fni0xqll-1226695290774
http://www.lastampa.it/2013/08/12/esteri/al-qaeda-rivendica-gli-attentati-in-iraq-e-minaccia-gli-sciiti-non-siete-sicuri-RVfsItAmqnUSWHCsk9xgbL/pagina.html
http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-18460804
http://www.repubblica.it/esteri/2013/04/05/news/una_nuova_carneficina_a_sumatra_lo_scontro_tra_buddisti_e_musulmani-56028118/
http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-22697104
http://world.time.com/2013/08/07/jakarta-bomb-a-warning-that-burmas-muslim-buddhist-conflict-may-spread/
http://freedomnewsgroup.com/2013/06/22/the-face-of-buddhist-terror/
http://wagingnonviolence.org/feature/disillusionment-and-disappointment-with-aung-san-sui-kyi/
http://www.economist.com/news/asia/21582321-fuelled-dangerous-brew-faith-ethnicity-and-politics-tit-tat-conflict-escalating